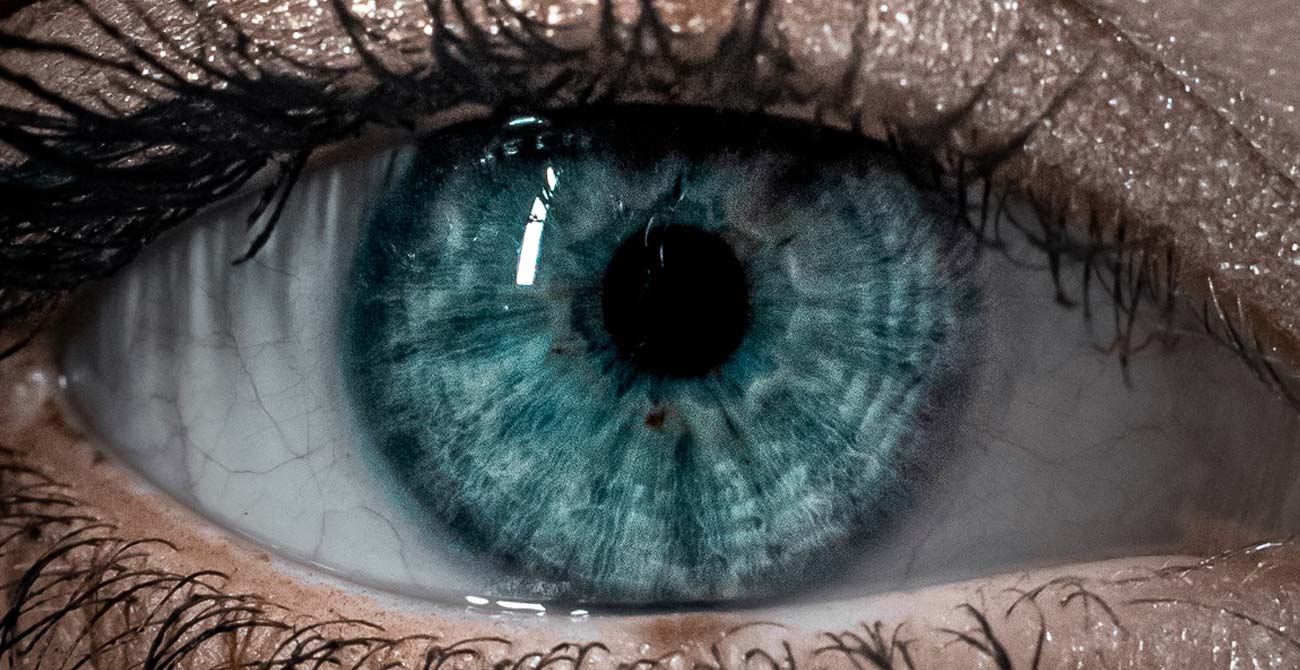
Visualizzazioni con tutti i 5 (e più) Sensi
Le Tecniche Immaginative o semplicemente di “Imagery” sono impiegate quotidianamente nella pratica clinica in numerose forme di psicoterapia, incluse le terapie di “terza onda” dell’ambito cognitivo-comportamentale, soprattutto la Schema Therapy (Arntz & Jacob, 2017) e l’Hypno-CBT, che unisce aspetti dell’Ipnosi e della Terapia Cognitivo-Comportamentale standard (Robertson, 2013).
In una sessione-tipo di Imagery, il paziente, dopo aver raggiunto uno stato di rilassamento, viene indotto a visualizzare ogni tipo di immagine e di scene, immaginando ora “luoghi sicuri” (ovvero scene paesaggistiche in cui il soggetto si sente calmo e a suo agio) da esplorare, ora scene traumatiche da rivivere e successivamente ristrutturare per superare tale trauma (come nell’Imagery Rescripting).
Il cliente spesso viene invitato a porre estrema attenzione ai dettagli delle immagini, in modo da renderle il più vivide possibili e alimentare la sensazione di realtà delle stesse, al fine di rendere l’esercizio più efficace.
Visualizzazioni Ripetute e Allucinazioni
L’etnologa T.M. Luhrmann ha investigato come l’attenzione ai dettagli e la vividezza delle visualizzazioni aumentasse via via che queste venivano ripetute. La Luhrmann ha condotto due ricerche: una prima sulle persone che praticavano forme di esoterismo occidentale e fedeli di religioni neopagane (come la Wicca), e una seconda su gruppi di cristiani evangelici che, nel loro pregare, credevano di ricevere messaggi da Dio.
Relativamente al primo gruppo, l’etnologa ha affermato: “Ho letto i loro libri e i loro romanzi. Ho praticato le loro tecniche ed eseguito i loro rituali. Ho scoperto che in massima parte i rituali dipendevano da tecniche di immaginazione. Uno chiude gli occhi e visualizza mentalmente la storia narrata dal leader del gruppo”.
Luhrmann rimase affascinata quando scoprì che, dopo circa un anno di questa pratica, la sua immaginazione era divenuta più chiara, dettagliata e concreta, mentre i suoi stati di concentrazione erano “più profondi e nettamente diversi dal quotidiano”. Una notte, scrive, si immerse in un libro sulla Britannia di Artù, “abbandonandomi alla storia e permettendole di far presa sui miei sentimenti e di riempire la mia mente”. Il mattino dopo, quando si svegliò, aprì gli occhi su una scena straordinaria: “In piedi, di fronte alla finestra che dava su una movimentata strada londinese, vidi sei druidi. Io li vidi, e loro mi fecero un cenno. Io rimasi a fissarli per un attimo di sconcertato sbalordimento, e poi mi buttai giù dal letto, ma quelli erano spariti. Erano stati lì in carne e ossa? Pensavo di no. Il mio ricordo di quell’esperienza, però, è chiarissimo […] Ricordo d’averli visti chiari e distinti, esterni a me proprio come il quaderno su cui annotai l’evento. Lo ricordo così chiaramente perché era molto singolare. Prima, non mi era mai accaduto nulla del genere”.
Per quanto riguarda il secondo gruppo, fra gli evangelici ve ne sono molti che credono di essere stati letteralmente toccati da Dio, o di averlo sentito parlare ad alta voce; altri dicono di percepire fisicamente la sua presenza, di sapere che egli è là e cammina accanto a loro. Come scrive Luhrmann, nel cristianesimo evangelico l’enfasi è posta sulla preghiera e su altri esercizi spirituali quali abilità da apprendere e praticare. Probabilmente essi risultano più facili a coloro che tendono a farsi coinvolgere e assorbire completamente dalle proprie esperienze, reali o immaginarie che siano: si tratta, scrive Luhrmann, della capacità “di concentrarsi sull’oggetto della mente […] la modalità del lettore di romanzi, dell’ascoltatore di musica e del camminatore della domenica, completamente immersi nell’immaginazione o nel godimento dell’attività”. Una tale capacità di lasciarsi assorbire, secondo Luhrmann, può essere affinata con la pratica, e questo è, in parte, ciò che accade con la preghiera. Spesso, le tecniche della preghiera si concentrano sull’attenzione al dettaglio sensoriale: “[I fedeli riuniti] esercitano mentalmente la vista, l’udito, l’olfatto e il tatto. Essi conferiscono a queste esperienze immaginate l’intensità sensoriale associata ai ricordi di eventi reali. Per loro, ciò che sono in grado di immaginare diventa più reale.”
Poi, un giorno, la mente compie il balzo dall’immaginazione all’allucinazione, e il fedele sente Dio, vede Dio. Queste voci e visioni ardentemente desiderate hanno il carattere reale della percezione. Uno dei soggetti di Luhrmann, Sarah, si espresse in questi termini: “Le immagini che vedo [durante la preghiera] sono molto limpide e reali. Diverse dal semplice sognare a occhi aperti – voglio dire, a volte è quasi come una presentazione in PowerPoint”. Con il passare del tempo, scrive Luhrmann, le immagini di Sarah “si fecero più ricche e complicate. Sembravano avere bordi più netti. Continuarono a diventare sempre più complesse e più definite”. Le immagini mentali diventano chiare e reali come il mondo esterno. Sarah ha avuto molte di queste esperienze; alcuni fedeli probabilmente ne hanno una sola; ma per sostenere la fede di tutta una vita può bastare anche solo una singola esperienza di Dio, pervasa dall’irresistibile incisività della percezione reale (Luhrmann 1989, 2012, 2020; Sacks, 2013).
Sensi fisici e sensi immaginari
I sensi fisici sono: vista, udito, gusto, olfatto, tatto, che include anche la nocicezione (percezione del dolore), la pressione e la consistenza (la cosiddetta “texture”), e la temperatura (Atkinson & Hilgard, 2011). A questi possiamo aggiungere la percezione motoria ovvero del movimento, la propriocezione e la percezione dell’equilibrio, responsabili dunque della postura, della posizione degli arti e quindi dei gesti delle mani e delle posizioni del corpo e della loro percezione.
A livello interno possiamo aggiungere emozioni, sensazioni, intuizioni, pensieri, immagini mentali, e corrispettivi interiori dei sensi esteriori (percezioni interiori di tatto immaginato, gusto immaginato e così via).
Questa lista ovviamente non è esaustiva, ma tanto basta per far comprendere come la percezione sensoriale non sia un argomento così semplice e lineare, e dunque altrettanto complesso sarà il traslare la percezione degli oggetti esterni (come nella vita di tutti i giorni) in una percezione immaginaria con tutti i vari sensi.
Allucinazioni Multimodali
Le allucinazioni possono avvenire in una modalità singola o in modalità sensoriali multiple. Storicamente, è stata posta una maggiore attenzione alle allucinazioni che avvengono con modalità sensoriali singole rispetto a quelle che occorrono con due o più modalità sensoriali, dette allucinazioni multimodali.
La ricerca suggerisce che le allucinazioni visive sono spesso esperite assieme ad altre allucinazioni, e che le allucinazioni multimodali siano dunque più comuni di quanto normalmente si creda (Dudley et al, 2018; Chesterman & Boast, 1994).
C’è anche chi ha distinto tra allucinazioni multimodali, in cui due o più modalità sensoriali sono presenti contemporaneamente, e allucinazioni multisensoriali, in cui le diverse modalità sensoriali sono presenti in momenti diversi (Toh et al, 2021).
Dalle Allucinazioni Multimodali alle Visualizzazioni Multimodali
Se dunque, come abbiamo visto, l’allucinazione non è altro che un’immaginazione che ha fatto un “balzo”, e le tecniche di Imagery – come suggerisce il nome – si basano sull’immaginazione, sarà necessario, nel loro impiego clinico, sfruttare tutte le modalità sensoriali e non solo quella visiva od uditiva.
Sarà dunque compito del clinico chiedere al paziente, durante una visualizzazione guidata (vista) in terapia, di fare attenzione ai suoni che sente (udito), alle sensazioni tattili (tatto), agli odori e ai profumi che percepisce (olfatto), al caldo e al freddo (temperatura), alla pressione e alla consistenza degli oggetti (texture), ai propri movimenti (cinestesia), all’equilibrio, alla posizione o postura del proprio corpo e ai gesti che si eseguono (propriocezione), ai sapori o alla percezione di ciò che si sente in bocca, sulla lingua, sul palato e sui denti (gusto), al respiro e al battito del cuore (sensazioni fisiche), a ciò che si sente sul corpo (sensazioni corporee), alle emozioni, alle immagini mentali, agli insight o intuizioni, ai pensieri, alle spinte all’azione o impulsi, e molto altro.
Se a ciò si aggiunge la visione in prima persona (immaginare e sentire di vedere come se si fosse lì, immaginando come se si stesse guardando – ascoltando, ecc. – con i propri occhi – od orecchie, ecc. – e non in terza persona come solitamente accade nelle visualizzazioni), l’esercizio di Imagery ne uscirà rafforzato, perché sarà sicuramente molto più vivido e dunque efficace.
Riferimenti:
Arnoud Arntz, Gitta Jacob. (2017). Schema Therapy in Practice. An Introductory Guide to the Schema Mode Approach. John Wiley & Sons.
Robertson, D. (2013). The practice of cognitive-behavioural hypnotherapy: A manual for evidence-based clinical hypnosis. Karnac Books.
T.M. Luhrmann. Persuasions of the Witch’s Craft. Ritual Magic in Contemporary England. Harvard University Press, 1989.
T.M. Luhrmann. When God Talks Back. Understanding the American Evangelical Relationship with God. Vintage Books, 2012.
T.M. Luhrmann. How God Becomes Real. Kindling the Presence of Invisible Others. Princeton University Press, 2020.
Oliver Sacks. Allucinazioni. Adelphi, 2013.
Rita L. Atkinson, Ernest R. Hilgard, Susan Nolen-Hoeksema. Atkinson & Hilgard’s. Introduzione alla Psicologia. Piccin-Nuova Libraria, 2011.
Dudley R, Aynsworth C, Cheetham R, McCarthy-Jones S, Collerton D. Prevalence and characteristics of multi-modal hallucinations in people with psychosis who experience visual hallucinations. Psychiatry Res. 2018 Nov;269:25-30.
Toh WL, Bere M, Rossell SL. Distinguishing multimodal versus multisensory hallucinations in psychosis: Key definitions and a way forward. Aust N Z J Psychiatry. 2021 Jul 13:48674211031455.
Chesterman P, Boast N. (1994). Multi-Modal Hallucinations. Psychopathology, 27(6), 273–280.



